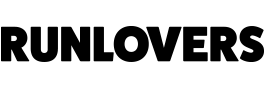Comincio dalla fine, con una provocazione che lo è solo fino a un certo punto: la montagna è pericolosa. Punto. Si rischia di farsi male – poco o tanto che sia –, si rischia di morire.
Ah ma signora mia, lo sa quante persone vengono tirate sotto da un’auto in città? Sì, lo so, vivo a Milano e se non mi guardo in giro con dodici occhi, a piedi e in bici, rischio la vita tutti i giorni. Ma non è questo il punto. Perché qui stiamo parlando di un luogo che è intrinsecamente pericoloso, per sua natura, a prescindere dal comportamento altrui.
Con questo non voglio certo dire che non devi (non dobbiamo) andare in montagna, tutt’altro. Sto dicendo piuttosto che bisogna andarci con enorme rispetto e – questa per me è la parola chiave – consapevolezza. Consapevolezza dei luoghi, consapevolezza di quello che si sta per fare – che sia una passeggiata, una corsa, una ferrata o qualsiasi altra attività –, consapevolezza dell’eventuale attrezzatura necessaria per farlo.
Una questione di accessibilità
Non sono mai stato e probabilmente mai sarò contro il progresso tecnologico: non rimpiango le carrozze, adoro il mio iPhone, non penso che stessimo meglio cinquant’anni fa.
Quello che in moltissimi settori ha fatto il progresso è principalmente ridurre (in alcuni casi azzerare) le distanze reali o metaforiche dell’accesso a qualcosa. Faccio un paio di esempi banali: costruire una strada che prima non esisteva permette a persone (merci, cultura eccetera) lontane di incontrarsi più facilmente; l’invenzione del telegrafo (telefono, radio, TV eccetera) ha permesso di comunicare istantaneamente annullando virtualmente distanze enormi. Difficile affermare che stessimo meglio prima, almeno per quanto mi riguarda.
Tornando al tema della montagna appare evidente che costruire una strada permette a chiunque di raggiungere, con grande facilità, un luogo che prima era raggiungibile a pochi volenterosi e particolarmente in forma. Il discorso è ancora più valido quando parliamo di impianti di risalita che permettono di raggiungere vette spesso inaccessibili ai più. E qui arriviamo al punto: il fatto che qualcosa sia accessibile non significa automaticamente che sia per tutti. Il fatto che una vetta fosse raggiungibile in precedenza solo da alpinisti o escursionisti molto esperti faceva sì che ci fosse una sorta di selezione naturale che garantiva il suo raggiungimento solo a chi fosse in grado di affrontare il viaggio, sia dal punto di vista dello sforzo fisico che da quello della difficoltà tecnica. Ora che chiunque la può raggiungere con la funivia si pone un tema di sicurezza e – appunto – consapevolezza; perché chi sale in funivia poi vuole (giustamente?) andarsene in giro o magari scendere a piedi, come se scendere fosse poi più facile che salire. E io ne ho viste troppe di famiglie in ciabatte, passeggino (giuro, non sto scherzando) e canotta a 3.000 m su sentieri impervi e pericolosi con un freddo cane per non pensare che tutto questo – gestito così, anzi non gestito – abbia qualcosa di sbagliato a monte. Inutile peraltro condannare la povera funivia, che in sé è solo un utilissimo strumento, sarebbe come dare la colpa al coltello e non all’assassino. Il mio punto – l’ho già detto? – è la consapevolezza di quanto si sta facendo e ahimè mi accorgo sempre più di quanto sia inversamente proporzionale alla crescita del numero di persone che si approccia alla montagna. Limitare l’accesso? Non credo sia la soluzione. Educare, forse.
Lo scontro generazionale
Chiunque frequentasse la montagna già trent’anni fa sa benissimo come si usava andare in montagna trent’anni fa: scarpone che più alto è meglio è, calzettoni inguinali, camicia di flanella, pantaloni alla zuava e zaino da un milione di litri. Senza divagare nell’ambito prettamente estetico posso dire che è un settore dove abbiamo fatto passi da gigante, a partire da materiali e tecnologie per arrivare alla forma mentis con la quale ci approcciamo all’escursionismo in tutte le sue varianti. Quando vedo un gruppo di scout in mezzo ai monti con le loro camicie di cotone e il calzettone di spugna vorrei solo chiedere loro perché?

Da quando pratico trail running ho imparato a muovermi sempre più leggero, anche durante una semplice passeggiata, riducendo all’osso il materiale senza che questo significhi però rinunciare alla sicurezza: semplicemente oggigiorno si può avere un abbigliamento caldo e impermeabile che pesa una manciata di grammi e che spesso ti puoi infilare in tasca. L’altra grande verità che ho scoperto grazie a questo sport riguarda le calzature: lo scarpone alto, pesante e strutturato non è sempre e comunque la migliore scelta, anzi. La consapevolezza di cui sopra riguarda anche (soprattutto?) quella verso sé stessi, nei confronti del proprio corpo e delle proprie capacità. Il suddetto scarpone sicuramente ti protegge maggiormente da scavigliate e altri infortuni simili, ma ti toglie una notevole libertà di movimento e sensibilità nei confronti del terreno che stai calcando. E invece quello che fa il nostro corpo, se gliene diamo l’opportunità, è imparare e adattarsi. Chiaro che il passaggio deve essere graduale, benvenga lo scarpone per chi va in montagna la prima volta, ma oggi nel 90% delle miei uscite montane indosso delle scarpe da trail running: basse, molto leggere e con una suola relativamente sottile. E quello che vorrei dire alla guida CAI (è uno stereotipo: sono da anni socio CAI e non smetterò mai di ringraziarli perché in Italia se esistono i sentieri lo dobbiamo perlopiù a loro) che quando mi incontra scuote la testa e borbotta parole poco lusinghiere è che non lo faccio perché sono stupido o incosciente: tutt’altro. Lo faccio perché ho allenato il mio piede, le mie gambe e il mio equilibrio. Lo faccio perché sono enormemente cosciente dei miei limiti e non potrei esserlo se avessi continuato ad affrontare ogni sentierino vestito come per raggiungere l’Annapurna. E quando corro a perdifiato (naturalmente io mi immagino come Kilian Jornet ma poi quando riguardo i video ricordo più Giampiero Galeazzi) giù da una pietraia lo sto facendo con una naturalezza che deriva da anni di allenamento graduale che mi ha portato a poterlo fare oggi.
Le gare
Qui mi allontano in parte dal tema outdoor più generico per concentrarmi più sul trail running, le cui gare se vogliamo rappresentano alcuni dei momenti più rischiosi: se è vero che c’è maggiore possibilità di assistenza in caso di infortunio rispetto a un’analoga uscita con gli amici è infatti altrettanto vero che in quel frangente cerchiamo di superare i nostri limiti emendando parte della sicurezza in favore della prestazione. Inoltre parliamo di attività svolte in semi o totale autosufficienza, a seconda dei casi.
Nello specifico – visto il tema che stiamo trattando – ci sono due questioni che spesso riguardano una gara: il numero di punti ITRA (International Trail Running Association) necessari per parteciparvi e il materiale obbligatorio. Sono entrambe questioni legate al tema della sicurezza, anche se sui punti ITRA (ai quali peraltro ddi recente si sono aggiunti i punti UTMB, ma ne parliamo un’altra volta) si potrebbe discutere a lungo, ma ti tranquillizzo: non oggi.
Semplificando il più possibile si può dire che i punti ITRA definiscono la difficoltà di una gara. Per fare una gara da 3 punti devi averne portata a termine almeno una da 2 punti nei mesi precedenti (solitamente 18, ma dipende) all’iscrizione e così a salire: per fare una gara da 4 punti devi averne presi 3 eccetera. Disclaimer a beneficio dei più esperti, sto semplificando, lo so che non è esattamente così, ma è inutile addentrarsi in tecnicismi in questa sede. Così – oltre a sfoltire evidentemente le fila dei potenziali partecipanti – si evita che qualcuno possa presentarsi alla linea di partenza di una gara da 120 km e 6.000 m di dislivello senza avere contezza di quello che sta facendo.
Allo stesso modo il materiale obbligatorio (giacca impermeabile di un certo tipo, riserva minima d’acqua e di cibo, telo di emergenza eccetera) viene definito dagli organizzatori affinché nessuno dei concorrenti sia sprovvisto di qualcosa di necessario ad affrontare quella specifica competizione. Resta inteso che il materiale aumenta o cambia a seconda della difficoltà del tracciato di gara, della sua lunghezza e delle condizioni meteorologiche contingenti.
Va però detto che questa cosa del materiale obbligatorio riguarda principalmente le gare europee – spesso per motivi assicurativi – e questo fa da trampolino per far sentire al riguardo anche l’altra campana: un altro approccio, più selvatico ma non per questo più stupido. Siamo in montagna, la montagna è pericolosa, ti sto fornendo tutte le informazioni necessarie riguardo al gara – meteo, dislivello, lunghezza, difficoltà, mappa, roadbook, foto, video, ristori, tutto quello che vuoi –, sei una persona adulta e con quale preparazione o materiale ti presenti alla partenza sono un po’ fatti tuoi.
Ecco. Naturalmente io capisco benissimo che chi organizza una gara non sarebbe felice di avere centinaia di ritiri, infortuni o – sì, è da mettere in conto – morti. E quando va male regolarmente si fanno le pulci agli organizzatori per non aver pensato a tutti gli scenari possibili e improbabili. Per questo si fa il possibile per permettere a tutti di gareggiare nelle condizioni ottimali. Ma con il cuore non posso non chiedermi perché sia necessario farsi carico dell’ignoranza o stupidità altrui. Anche perché ti garantisco che il materiale che serve a Kilian per fare una gara è un decimo di quello che serve a me (per ora, beninteso). E lui lo sa bene. E io lo so bene.
Consapevolezza.
[Cover photo by lucas Favre on Unsplash]